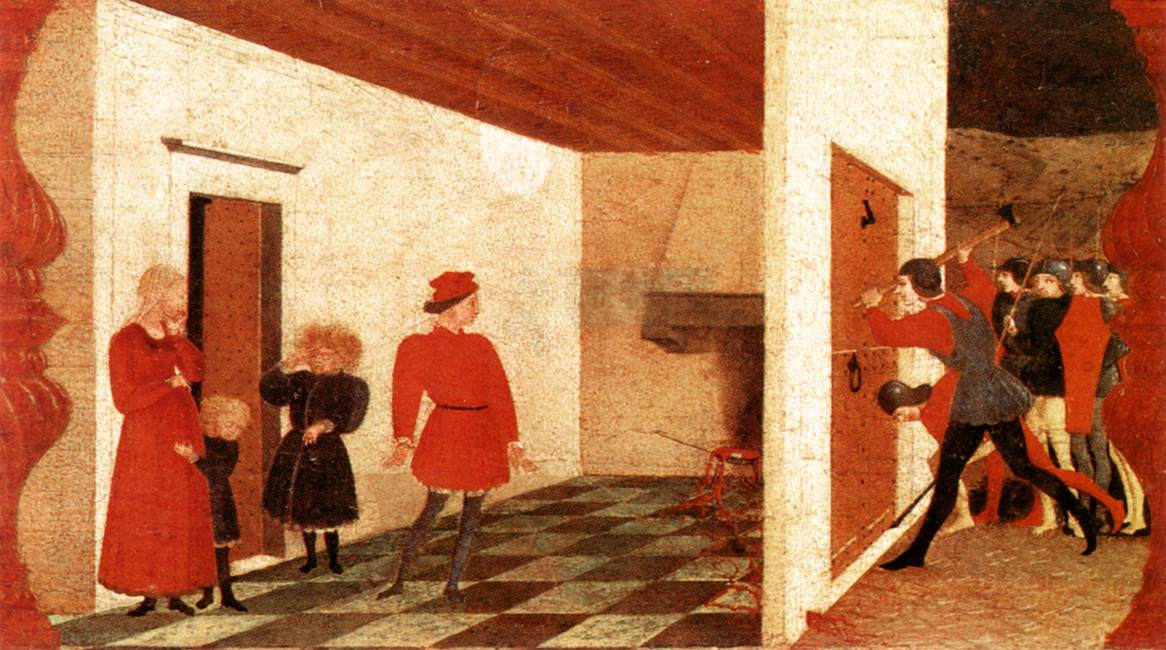Due incognite e due voci, Andrea Rinaldi_Roma
Racconto finalista Premio Energheia 2021_XXVII edizione – sezione giovani
Erano passati diversi mesi da quella crudele sera di febbraio che aveva ricongiunto con l’inganno le strade del Matematico e della Pianista solo per poi costringerli a separarsi di nuovo. Nessuno dei due avrebbe mai dimenticato quel concerto a cui lui aveva assistito quasi per errore, senza sapere chi avrebbe suonato, né la sublime arroganza delle note suonate da lei che scossero l’auditorium fino all’ultima fila di spettatori e a cui solo il soffitto impediva di fuggire su nel cielo a incantare le stelle. Non avrebbero dimenticato nemmeno quel silenzio glaciale che seguì il concerto quando, in mezzo ad ali di folla che si chiudevano a osservare la loro unione, lui era scappato, pentito di quello che aveva fatto e di averglielo ricordato. Quel silenzio glaciale, incorniciato dai fiori di neve di quella notte scura, che cadevano in soffici vortici sui capelli della Pianista, lui lo ricordava bene e non avrebbe mai potuto cancellarlo dalla memoria. Non avrebbe mai dimenticato gli occhi della Pianista, una volta, occhi smeraldini di una sognatrice e di un’artista: poi, prima ancora di quel concerto, scuri e umidi come una palude e gonfi di tempesta. Si erano voltati via e non erano mai più tornati come prima. Chissà se la musica della Pianista aveva la stessa potenza vibrante di allora che aveva conquistato il cuore del Matematico. A lui pensava ancora? Lui preferiva pensare di no. Sarebbe stato meglio per entrambi dimenticarsi l’uno dell’altra e vivere come se non fosse mai accaduto nulla. Perché non sarebbe mai dovuto accadere nulla. Però, in cuor suo, era sicuro che lei lo ricordava ancora e per questo si struggeva. Se non fosse ancora vivo tra i suoi pensieri perché quella sera lei l’avrebbe seguito fuori dall’auditorium, correndo sui tacchi tintinnanti? E perché l’avrebbe guardato con quegli occhi? Non avrebbe mai dovuto portarle alla memoria quell’errore imperdonabile che aveva commesso e che ora gli logorava la mente, scuro e fastidioso come il tratto di un pennarello indelebile che si può solo tentare di coprire con… scarabocchi! La suoneria del telefono lo riscosse e si rese conto che con la penna stava martoriando il foglio che avrebbe dovuto firmare: con un sospiro lo accartocciò e lo buttò, rendendosi conto che era insalvabile, poi lesse la notifica: “Arrivo tra dieci minuti”. Era dell’Insegnante, la sua collega della cattedra di storia. La loro era un’amicizia davvero strana, ma funzionava. Solo qualche giorno prima, in una di quelle conversazioni all’intervallo, brevi quanto il consumarsi di una sigaretta, si erano entrambi scoperti giocatori di scacchi e avevano deciso di sfidarsi. Il Matematico si alzò di controvoglia dalla sedia scorticata che se ne stava appollaiata di fronte alla finestra, e con lo sguardo cercò la scacchiera, sepolta da qualche parte nei labirintici scaffali del suo studio, disseminato di fogli che se ne stavano come cadaveri violati e insepolti. E mentre la cercava si chiedeva perché non riuscisse a smettere di pensare a lei. Forse perché quello che era successo tra loro due era simbolo lampante del suo fallimento? Lui non faceva altro che cercare di non commettere errori, tanto nella sua rigorosa e precisa disciplina quanto nella vita e nei rapporti: la logica conseguenza era, quindi, essere rigoroso e disciplinato in ogni aspetto. Eppure con lei non era bastato, anzi, non era servito; anzi, peggio ancora, era stata la stessa causa della fine: era colpa sua. Forse loro due non erano compatibili? Forse era stato un errore di calcolo fin dal principio? No. A questo lui non voleva credere. Così rimuginava vagando per lo studio: poi, finalmente vide la scacchiera, sepolta da una pila sgangherata di fogli su uno scaffale basso. La tirò fuori e dal mucchio sovrastante cadde un foglio solitario: normalmente l’avrebbe lasciato lì, perché certamente un foglio in più non avrebbe reso il posto più disordinato. Però poi si fermò: era uno spartito per pianoforte. Posò in fretta la scacchiera e lesse avidamente quello che c’era scritto: “Inventio VIII – Johann Sebastian Bach”. Sussultò. «È un’invenzione a due voci,», gli sembrò di risentire la voce di lei, un vivido ricordo di quando lei, al telefono, si metteva a spiegargli teoria musicale e lui, anche se non ne sapeva nulla e non riusciva a capire, l’ascoltava parlare, felice solo di sentire la sua voce così entusiasta. «un tipo di brano in cui le due mani – appunto le due voci – si rispondono a vicenda sulla base di uno stesso motivo; e proprio per questa loro natura le invenzioni a due voci sono particolarmente difficili.» Ricordava anche il suono ritmico del treno sulle rotaie, come un leggero disturbo della linea. «Le due voci si sostengono e si danno forza e significato a vicenda; e un errore di una delle due porta giù con sé anche l’altra». Il Matematico sbatté le palpebre. Perché quel ricordo gli era tornato a mente così nitido? Si riscosse – o almeno ci provò – e, lasciando lo spartito lì, si diresse con la scacchiera in mano in sala da pranzo. Ma non riusciva a smettere di farsi quella stessa domanda e a chiedersi in generale perché non riuscisse a dimenticare. Forse era solo superbia: non riusciva a togliersi di dosso la bruciante sensazione di aver sbagliato. Si convinse che era così, mentre posava la scacchiera sul tavolo ed estraeva i pezzi per disporli in ordine, come avrebbe voluto fare coi suoi pensieri: ma i suoi pensieri, briganti scatenati, ignoravano ogni suo sforzo. Forse non era superbia la sua, forse c’era qualcos’altro, quel sentimento che lo aveva spinto a correre da lei dopo il concerto e che per un po’ era stato più forte della paura che l’aveva poi convinto a fuggire. Forse… mentre allungava la mano verso la regina bianca il campanello suonò. Andò ad aprire. L’Insegnante era lì sulla porta, con i suoi soliti occhi sottili e stanchi e il sorriso apatico disteso sul volto, avvolta nel suo tailleur grigio. «Ciao» lo salutò; «Ciao, la scacchiera è già sul tavolo» rispose lui e, senza aggiungere altro, si voltò, andando a prendere posto. L’Insegnante lo seguiva come un’ombra e lui, senza capirne il perché, si sentiva osservato e a disagio. Sapeva che l’amica aveva una pessima abitudine, ossia frugare tra i pensieri degli altri con un semplice sguardo, grazie alla sua straordinaria capacità di indagine. Aprì lei il gioco. Non si dissero molto: entrambi concentrati, ma nessuno dei due aveva la mente focalizzata sulla partita. Lei cercava di capire il motivo del suo comportamento; e lui lo stesso. «Sai,» sibilò l’Insegnante, a un certo punto, «giocare con te è davvero noioso. Giochi come una macchina». Il Matematico alzò lo sguardo. «Come sarebbe a dire?» chiese. «Non giochi né per il gusto di giocare né per vincere: giochi semplicemente per non perdere» rispose e lui, guardandola negli occhi, capì immediatamente il motivo di quell’interruzione e subito abbassò lo sguardo. «Ti terrorizza l’idea di sbagliare e soprattutto ti terrorizza che, per colpa del tuo errore, cambino le sorti della partita. Non è così?». Quelle parole rimbombarono nella mente del Matematico, mentre aveva la mano su un cavallo. Sentiva gli occhi dell’Insegnante puntati su di lui. Le dita cominciarono a tremargli e gli parve che la pedina si muovesse per sfuggire dalla sua presa. “Tu giochi per non perdere”: a quelle parole si ravvivò il ricordo di lei e di tutti gli errori imperdonabili che lui aveva commesso. Con una sonora schicchera colpì il suo re e lo mandò a stramazzare in mezzo alla scacchiera. Teneva lo sguardo fisso sul pezzo, che rotolava come se agonizzasse. E alla fine riuscì a pronunciare quello che gli stavano comunicando tutti quei pensieri, assoluzione e condanna della sua memoria crudele: «Voglio tornare da lei». «Allora è questo che avevi per la testa. Era ora» rispose compostamente l’avversaria dopo qualche secondo. «Andiamo» aggiunse, alzandosi dalla sedia e dimenticandosi della partita. «Però» la interruppe lui, tenendola per un braccio, «Io non… non credo di meritarlo. Ho sbagliato su tutta la linea, capisci? È stata colpa mia, non merito una seconda opportunità da lei». L’Insegnante sospirò. «Smettila di pensare che tutto il mondo sia un problema di matematica. Non sai come funziona il mondo e come si risolvono i problemi» disse, con tono freddo, «Quello che è passato è passato: non si può correggere, certo, ma non è nemmeno una condanna incombente su tutte le azioni successive. In storia funziona così: gli errori capitano e spesso sono la causa dei successi futuri, perché il dolore e la sconfitta sono i migliori insegnanti, purché non li si ripudi. E la tua vita, la sua e la vostra insieme sono una storia: non potete fuggire dal passato e non potete ricordarlo come un’età dell’oro. Dovete vivere in conseguenza di quel passato e imparare da esso, invece di non fare nulla per il timore che si presenti di nuovo». «Però…» iniziò lui; ma l’Insegnante lo interruppe: «Non c’è nessun però. Hai fatto un errore. Ciò non ti rende un mostro e non rende lei un angelo». Lo guardò con occhi più gentili, con un velo di malinconia, e mormorò dolcemente: «Vedo quanto il rimorso ti divora… ma anche fallire questo tentativo sarà meglio del rimpianto di non aver mai nemmeno provato a rimediare, o no?». Rimase ancora lì fermo, con le mani tremanti. Era una mossa azzardata e non sentiva di essere in grado di farla. «Capisco che tu tema di sbagliare di nuovo, per difendere te stesso e lei» gli sussurrò l’Insegnante, avvicinandosi a lui e mettendogli una mano sulla spalla «ma se la paura di farti male soffoca il desiderio di essere felice, finirai per consumarti all’ombra della perfezione e del rimpianto». Senza dire una parola il Matematico scivolò come un’ombra fino in macchina e l’Insegnante lo seguì; poi partirono. E nell’ombra del suo cuore, lui cercava la luce della Pianista: ma ora lei tra i muri della sua casa buia cercava di far sentire alla polvere sulle pareti la voce della sua anima. Richiamava alla mente tutte quelle emozioni burrascose , come fossero spiriti antichi che davano ali alle sue dita e le permettevano di trasmutarsi in qualcos’altro, qualcosa di nobile e di vivo: pensò al suo primo concerto, al suo primo giorno in conservatorio; e poi senza volerlo pensò a lui che scappava sotto la neve e tutto crollò in un attimo. Le dita inciamparono, stonarono e quell’idillio si spense d’improvviso. Rimase con le mani ferme sulla tastiera, incapace di riprendere. «Sbagli per troppo trasporto: ma va bene così, vuol dire che sei ancora una musicista pura nell’anima, non ancora ossessionata con la tecnica» le diceva la sua docente di musica ogni volta che si crucciava per quei continui nove e mezzo che prendeva agli esami. Le mancava sempre mezzo voto. Per troppo trasporto. Si mise il volto tra le mani; poi si alzò dallo sgabello, quasi nauseata, e andò a farsi il caffè in cucina. Perché aveva di nuovo pensato a lui? Perché continuava a pensarci? Era finita. Ed era stata colpa sua, della sua eccessiva passione. Lui era sempre stato così perfettamente razionale, non si era mai sbilanciato: lei no. Era sempre stata troppo sensibile e passionale. E alla fine ecco il risultato di quella sua anima pura da musicista! Anche lei, tra un sorso e l’altro, si dava la colpa: poi posò la tazzina vuota su un tavolino e si appoggiò al davanzale della finestra a rimuginare. «Quel mezzo voto è il prezzo che deve pagare chi ha l’anima dell’artista prima che le mani» le aveva detto la sua docente di pianoforte. Ma ne valeva la pena? Valeva la pena di avere tutta quella passione e tutto quel trasporto, se la conseguenza era quel «mezzo voto» così crudele da sopportare? Avrebbe potuto abbassare le persiane: così nessuno avrebbe visto quello che succedeva dentro. Però chiudendosi in sé neanche lei avrebbe potuto vedere il mondo, sedersi a guardare il cielo, le nuvole che si rincorrevano scherzose e andavano a sovrapporsi e confondersi tra loro, il sole che a ogni tramonto s’inventava colori e forme nuove con cui dipingere il cielo, il vento che giocherellava con gli alberi e dava nuova vita e libertà alle foglie morte. La sua vergogna e la sua rassegnazione erano davvero abbastanza grandi da rinunciare a tutto ciò? Sospirò indecisa. L’aria era immobile, come se tacesse per rispetto della Pianista, in attesa che riprendesse a suonare. Il sole scendeva tranquillo come un vecchietto a passeggio e riempiva di rosso il cielo senza nuvole. L’unico rumore che si sentiva era il motore di una macchina che si avvicinava. Affacciandosi la vide di sfuggita che compariva in fondo alla strada; poi tornò dentro e abbassò le persiane. Si avvicinò al comodino su cui aveva appoggiato la tazzina per accendere l’abat-jour rossa e scacciare l’ombra che si era gettata addosso: e quando la luce giallognola e ronzante dilagò sul comodino e poi, più fioca, nella stanza intera, illuminò un mucchio di fogli che la Pianista aveva appoggiato lì distrattamente mentre faceva pulizie: e uno di loro catturò la sua attenzione. Era coperto di numeri e simboli scritti da due grafie diverse: la sua bella grafia ordinata e un’altra, spigolosa e rozza. Si sentì mancare il respiro. Prese il foglio e lo lesse avidamente: quegli stessi numeri e simboli lo ricoprivano davanti e dietro. Si girò lentamente a guardare il tavolo vuoto e ombroso al centro della stanza e le sembrò di vedere se stessa e lui, seduti, che parlavano. Lui aveva messo sul tavolo un mucchio di fogli da correggere e lei ne aveva intravisto uno su cui era scritta qualche equazione in una calligrafia molto ordinata, decisamente diversa da quella del Matematico. «Non dirmi che hai imparato a scrivere» lo aveva canzonato lei, sfilando il foglio dalla pila e iniziando a leggere quello che c’era scritto, una parentesi graffa che conteneva due equazioni. «Che?» chiese lui, che era impegnato a compilarne un altro; poi aggiunse, vedendo che cosa la Pianista aveva in mano: «Ah, no, ho fatto ripetizioni a un ragazzino, il figlio di quel vicino di casa dei miei, Aldo». «Che cos’è?» chiese lei, indicando la parentesi e le equazioni «Non me le ricordo queste». «È un sistema di equazioni a due incognite:» spiegò lui «vedi, ci sono sia x che y; si devono trovare entrambe e chiaramente il valore di una dipende da quello dell’altra». «E chiaramente se una delle due è sbagliata…» iniziò lei e lui concluse: «… l’altra non può essere giusta». Tacquero per qualche secondo, lui concentrato a compilare quel documento, lei a pensare. Poi commentò: «Mi sembra molto romantico». Lui alzò gli occhi dal foglio e ridacchiò. «Forse lo è,» disse «ma per me ormai sono solo esercizi fastidiosi che i ragazzi sbagliano sempre perché non sanno la differenza tra più e meno». Lei si mise a ridere e cominciò a punzecchiarlo per il suo cinismo. Poi sentì le sue parole passate sbiadire fino a diventare un mormorio confuso e distante e, sbattendo le palpebre, si trovò di nuovo nella cucina, buia se non per quell’alone giallo che non osava infilarsi fin negli angoli: e si sorprese a sorridere tra sé per quella memoria. Assorta com’era, non si era nemmeno accorta che nel frattempo il rumore di quella macchina in fondo alla strada non c’era più: e, assorta a crucciarsi per quel sorriso di cui si era scoperta colpevole, non sentì la portiera che sbatteva proprio là fuori. Aveva appena deciso di passare oltre, di dimenticare, di tagliarsi fuori da quel tumulto che era stata la causa di quel suo mezzo voto mancante e subito un ricordo così insignificante di nuovo la faceva sorridere. Guardò la finestra. Nonostante avesse abbassato la serranda, un po’ di luce tenace riusciva a filtrare e grattare via quell’ombra. Riguardò il foglio. Era questo il finale che voleva per il suo concerto? Un singolo accordo in piano, tenuto finché non si fosse spento da solo nell’aria ferma? Lei non era fatta per una vita senza trasporto, non per una senza sforzati, senza trilli, senza polifonie. A lei forse il mondo aveva destinato di non avere mai quel mezzo voto: perciò non doveva mai tradire sé e il suo stesso spirito per averlo. Continuava ostinatamente a dirsi che lui e tutto quello che avevano passato insieme erano ormai cose del passato e che non sarebbero mai tornate, ma si può davvero mai dire che un’emozione appartiene al passato, nonostante domini ancora così viva il cuore? Alzò la persiana e spalancò la finestra. Davanti a lei, stagliato sullo sfondo di un cielo rosato, vide il volo di un calabrone: roteava nell’aria, vibrando le ali senza pensieri, balzando di fiore in fiore ad arricchirsi di polline e a condividere quel che aveva. La Pianista rimase a fissarlo, focalizzò tutte le sue attenzioni su quel minuscolo punto, il punto in cui il mondo aveva concentrato tutta la sua libertà: nel volo lento e ronzante e libero di quel calabrone. Ma oltre il calabrone, oltre il prato e oltre la strada era appena sceso dalla macchina il Matematico e, nel vedere la finestra che si apriva e lei che appariva come dalla cornice di un quadro, sentì il cuore sobbalzare. In un attimo tutti i dubbi che aveva si sciolsero nell’aria e sentì solo di voler correre alla finestra e chiamarla: poi tornarono ad annodarglisi al collo come una cravatta troppo stretta e lui si irrigidì. Ricadde all’indietro, appoggiandosi alla portiera della macchina, e rimase a guardarla per un po’. Il suo viso, i suoi capelli, il suo sorriso erano una vista che non l’avrebbe mai stancato. E mentre stava lì ad ammirarla, come una ninfa circondata dai fiori del suo davanzale, si chiedeva: che risultato avrebbe avuto quell’espressione? Tante volte sono così piene di numeri e segni che ci s’imbarca sperando di trovare qualcosa e alla fine il risultato è zero. E se il risultato fosse stato quello? Niente? Scosse la testa. Il risultato era già stato zero una volta: ma quella volta aveva sbagliato e non sarebbe successo ancora. La Pianista in quel momento si riscosse e tornò dentro casa, chiudendo la finestra. Il Matematico guardò l’Insegnante che lo aspettava nella macchina: gli sorrideva e con lo sguardo lo incoraggiava ad andare. E lui mosse il primo passo e poi il secondo e poi altri ancora, finché non si trovò oltre la strada, a qualche metro dalla porta. Quante volte aveva percorso quel verde vicolo, si chiese mentre avanzava cercando di tenere la testa alta e di non farsi piegare dalla paura. Ogni volta l’aveva percorso con la stanca serenità di chi sa che sarà felice e che fuori dalla porta lascerà gli affanni come lascia l’ombrello grondante d’acqua. Ora invece camminava a passi lenti, ma non gravati dalla stanchezza: lenti per il peso dell’incertezza e dell’ignoto. Non sapeva che cos’avrebbe trovato quando quella porta, che ormai aveva davanti, avrebbe rivelato quello spicchio di mondo che un tempo era metà del suo. “Ma se la paura di farti male soffoca il desiderio di essere felice” si disse e alzò il pugno, avvicinandolo alla porta, “finirai per consumarti all’ombra della perfezione”. Bussò due volte, lentamente. E lei, da lì dentro, quante volte aveva percorso il corridoio che portava all’ingresso sapendo che cosa avrebbe trovato. Ma ora non sapeva e non aspettava nulla. Lo spioncino si mosse quasi impercettibilmente: ora anche lei lo aveva visto. Il Matematico avrebbe potuto temere che lei non aprisse, e mettersi a parlare e parlare e parlare per convincerla, oppure per riempire il suo ostinato silenzio di tutto quello che doveva dirle per poi non vederla mai più. Però – per qualche motivo che nemmeno lui seppe mai spiegarsi – sapeva che la Pianista avrebbe aperto, non importava quanto tempo fosse passato. E lei davvero aprì subito, forse per sua volontà, forse perché sapeva che anche se non avesse aperto lui sarebbe rimasto lì ad aspettarla per cent’anni ancora. Aprì dopo solo qualche istante: e molti altri istanti come quelli seguirono, istanti carichi di quel silenzio loquace e pieno di anticipazione che in un concerto segue un accordo in piano che ancora vibra impercettibile nell’aria grazie alla tenacia del pedale e lascia tutti gli spettatori tesi sul bordo del sedile, inconsapevoli se la musica continuerà o se possono lasciarsi ricadere sugli schienali, soddisfatti da quell’ultimo istante di anticipazione così freneticamente curiosa, così simile a quella stessa spinta inconscia che spinge le azioni e la ricerca umane. Istanti carichi del solo frinire delle cicale e di occhi che, nell’assenza di parole, avevano già comunicato tutto quello che serviva. Le uniche due parole che erano ancora necessarie, le uniche che il Matematico seppe pronunciare, furono: «Puoi perdonarmi?». E la risposta fu un abbraccio. La Pianista gli cinse il collo con le braccia: così i due che per troppo tempo si erano incolpati e che per troppo tempo avevano dubitato, come due rette che hanno viaggiato quasi parallele nell’infinità del piano e finalmente hanno raggiunto il loro punto in comune, si ricongiunsero: come due voci sole, incognite l’una all’altra, eppure intrecciate nel loro significato, nel dolore e nella gioia.